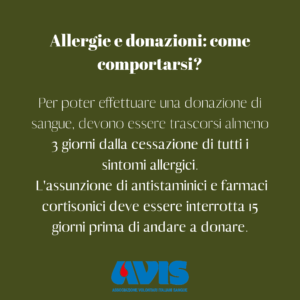Iniziamo oggi una rubrica che speriamo man mano di poter estendere in futuro, coinvolgendo altri donatori che possano lasciarci una loro testimonianza diretta della donazione, di cosa significa per loro donare, delle paure che hanno affrontato la prima volta e, perché no, qualche suggerimento sia per l’Associazione che per eventuali indecisi.
Con la speranza di riuscire, così, a convincere anche loro dell’importanza di un piccolo gesto.
Abbiamo chiamato la rubrica con una domanda: “Perché no?” che è per noi a sua volta la risposta a un’altra domanda: “Perché doni?”.
Non siamo riusciti infatti a trovare nessun motivo per non farlo (oltre, naturalmente, a motivi di salute, età, peso, ecc., comunque essenziali per la sicurezza di chi dona e di chi riceve).
Per inaugurare la rubrica, abbiamo intervistato Giacomo Colombo, giovane donatore avisino di Busto Arsizio, nonché volto di Avis Nazionale per la campagna del servizio civile (lo trovate anche in homepage sul loro sito www.avis.it!)
Ciao Giacomo! Per cominciare, perché non ci dici qualcosa su di te?
Sono Giacomo, ho 22 anni e sono di Busto Arsizio. Frequento il quarto anno di Ingegneria Civile al Politecnico di Milano e sono donatore dalla maggiore età. Ho giocato a tennis a livello agonistico e ho molte passioni, forse anche frutto del fascino per la complicazione e la conoscenza di derivazione ingegneristica.
Come sei diventato volto di AVIS Nazionale?
Sono stato contattato dalla segreteria di Avis Nazionale circa un mese prima del giorno dello shooting fotografico, attraverso il mio profilo Instagram @jackcolombo, dove solitamente condivido momenti della mia vita perlopiù felici. Lì sono anche presenti foto di mie esperienze passate da “modello”, per quanto certamente la ritenga più una passione/hobby che un lavoro.
Dopo una veloce presentazione di entrambe le parti son stato selezionato fra altri modelli per il servizio fotografico.
Il giorno dello shooting ho incontrato Boris Zuccon e Leandro Contino, Responsabili della Comunicazione di Avis Nazionale, oltre che i membri dello staff dello studio fotografico Photostudio 1619 Milan.
Con me vi erano un altro ragazzo e due ragazze, chi contattato mediante la propria Fashion Agency, chi, come me, mediante il proprio account Instagram.
Il team che si è creato è sembrato fin da subito energico, concentrato sul lavoro e molto partecipe, sicuramente un elemento distintivo di questa esperienza rispetto ad altre che ho avuto in questo campo.
Come ti senti a mettere la tua immagine al servizio di un’associazione importante come AVIS?
Sinceramente è stato un onore poter essere fotografato per Avis, perchè mi ha permesso di vivere da un altro punto di vista un’avventura iniziata con la donazione. È probabilmente l’esperienza, di questo tipo, che mi ha dato più ritorno fin da subito a livello emozionale e di orgoglio soprattutto.
La tua collaborazione con AVIS infatti non si esaurisce qui… Raccontaci della tua esperienza come donatore!
Sicuramente particolare è l’inizio. Tutto ha preso avvio con un evento organizzato alle superiori da un professore di educazione fisica, Maurizio Moscheni, che presentò a tutti gli studenti, mediante testimonianze e personalità di spicco, cosa volesse dire donare e essere uniti da un filo rosso. Originariamente provavo abbastanza fastidio alla sola vista di un ago, ma, come spesso mi capita di fare in situazioni scomode, ma che reputo interiormente profondamente giuste, preferisco correrci incontro chiudendo un po’ gli occhi, il giusto che mi permetta di “lanciarmi”.
Così, dopo l’iscrizione e la visita di controllo, ho donato per la prima volta. Inutile dire che il fastidio è stato superato e che non ho mai smesso.
Che cosa significa per te donare il sangue?
Come accennavo, andare periodicamente a donare mi permette di ritrovare una dimensione essenziale di umanità che se è tanto vero che di base dovrebbe interessare tutti noi, è altrettanto vero che nella quotidianità così spinta di una Milano frettolosa (che ho vissuto prima della pandemia, da pendolare, per diversi anni) si tende a dimenticare. Effettivamente per me donare è un piccolo sacrificio, perché fortunatamente non ho cali di pressione, giramenti o altro e ciò mi permette, a fronte di un piccolissimo momento di incertezza al contatto con l’ago, di mettermi in condizione di poter donare davvero molto. In una parola: la vita.
Qual è la tua parte preferita della donazione?
Ovviamente il panino con la mortadella. Scherzo, sicuramente il dedicare qualche ora e, generalizzando, la mattinata, al pensiero di cui parlavo prima: poter pensare agli altri e non a ciò che devo fare per me. Come dicevo, credo sia qualcosa di molto sottovalutato oggigiorno, da rivalutare.
Se tutto fosse possibile, qual è una cosa che cambieresti per agevolare la procedura della donazione?
Non penso di essere nella condizione di poter suggerire una logistica o, addirittura, una organizzazione migliore a chi raccoglie sangue da inizio secolo scorso. Credo solo di voler ricordare ancora una volta quanto sia importante raccontare cosa significa donare e magari, perchè no, invitare a provare (dopo prelievo di controllo e relativa idoneità, ovviamente). Nel mio mondo ideale penso possa essere magnifico veder donare tutte le persone idonee a farlo.